L’Italia è entrata a far parte del numero dei paesi meta di immigrazione, a partire dagli anni ottanta, proprio nel momento in cui a livello comunitario si sviluppavano politiche migratorie caratterizzate da un maggiore controllo e da una gestione più regolamentata dei flussi migratori.
In tale contesto, il nostro paese, caratterizzato da politiche migratorie ancora non ben strutturate, si è dovuto confrontare con una progressiva crescita di flussi d’immigrati, sia per la prossimità geografica a molti paesi di origine (in particolare il Nord Africa e l’Europa slava), sia per la presenza di specifiche condizioni quali la necessità di manodopera in settori a cui i cittadini italiani risultano sempre più scarsamente interessati. Sia per certe caratteristiche di immobilità sociale e demografica che rendono nel nostro paese più drammatico che altrove l’aumento del numero degli anziani e con esso la carenza nei servizi di assistenza, generando un bisogno di aiuto alle famiglie sempre più soddisfatto dalla manodopera “informale” garantita dalla presenza dei migranti.
Anche per quanto riguarda i rifugiati, la posizione dell’Italia cambia solo con il finire degli anni ’80: fino al 1989 infatti il nostro paese si caratterizzava prevalentemente come «un paese di transito o di permanenza breve, necessaria all’espletamento della procedura di resettlement, di re-insediamento in paesi d’oltreoceano». L’Italia è del resto stata un paese di transito durante tutto il periodo della guerra fredda in gran parte a causa di un tacito accordo internazionale e di una precisa logica politica: chi fuggiva dai paesi sovietici era considerato in Occidente un oppositore di regime; erano quindi gli Stati Uniti i primi a garantire a queste persone il trasferimento verso gli stessi Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, in base a specifici programmi di resettlement, creati ad hoc presso l’ambasciata di Roma.
È solo con l’abolizione della “limitazione geografica”, avvenuta nel 1990 con la legge Martelli, che l’Italia si apre alla necessità di essere paese di asilo e non solo di transito. Nel periodo intercorso fra gli accordi che portarono alla Convenzione di Ginevra e l’abolizione della limitazione geografica (raccomandata dal “Protocollo di New York” del 1967) il nostro paese era poi diventato uno dei più ricchi del mondo, e appariva ovvio, ai partner internazionali, che iniziasse ad assumersi maggiori responsabilità dei propri rifugiati.
Con la caduta del muro di Berlino e la fine dell’ordine bipolare che aveva diviso le influenze politiche nel secondo ventesimo secolo contrapponendo la sfera atlantica a quella sovietica, alla fine degli anni 80, venendo meno la motivazione politica che aveva dato luogo alla tutela dei fuggitivi da oriente, ebbero fine i programmi nordamericani e australiani di re-insediamento e l’Italia, rimasta in prima fila come paese alla frontiera sud del continente, si trovò a dover creare i primi strumenti di azione diretta come il Cir (Consiglio italiano per i rifugiati).
Attraverso la legge Martelli il nostro paese ha così posto le basi per l’introduzione di una nuova procedura di asilo e di un sistema di assistenza articolato, trasformandosi così in luogo di asilo. Ha però purtroppo continuato, e in parte continua tuttora, a considerare la questione dei rifugiati alla stregua di un aspetto marginale entro il più ampio problema dell’immigrazione,evitando così di investire nella professionalizzazione dell’amministrazione pubblica e ancora meno nell’accoglienza finalizzata all’integrazione.










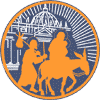












No comment yet, add your voice below!