 Not just football è un documentario di Paolo Casalis e racconta una storia incredibile: la nascita del Darfur United cioè di una squadra di calcio capace di tornare a fare parlare di Darfur, di conflitti e di rifugiati dimenticati.
Not just football è un documentario di Paolo Casalis e racconta una storia incredibile: la nascita del Darfur United cioè di una squadra di calcio capace di tornare a fare parlare di Darfur, di conflitti e di rifugiati dimenticati.
Una guerra ma soprattutto un popolo dimenticati trovano spazio nell’affollato mondo dei media grazie al calcio. Gabriel Stauring fondatore della ong californiana iACT ha un’idea: creare la nazionale di calcio del Darfur (Darfur United) e partecipare alla coppa del mondo. Paolo Casalis è un documentarista, classe 1976, che s’imbatte in questa storia e decide di raccontarla, lungo i 15 anni in cui si dipana la complicata matassa di un sogno diventato realtà. Vie di fuga l’ha intervistato per andare a vedere più da vicino di che si tratta.
Come mai hai scelto di raccontare questa storia? E come è avvenuto l’incontro con Gabriel Stauring?
Ho letto per la prima volta del Darfur United, squadra di calcio composta interamente da rifugiati dalla regione del Darfur, su un articolo della rivista Internazionale in cui si parlava della Conifa World Cup, una Coppa del Mondo di calcio per nazioni ufficialmente non riconosciute. Tra i nomi, accanto al Kurdistan, all’Occitania o alla Padania, spiccava quello del Darfur United, una squadra di calcio che rappresenta un intero popolo e che – e questo è il paradosso – nasce al di fuori della regione del Darfur, nei campi profughi del Ciad.
Dopo aver letto poche righe sulla storia del Darfur United ho cercato in rete il nome della squadra e mi sono imbattuto nella figura di Gabriel Stauring, fondatore di una ONG californiana che dal 2004 opera in Darfur, oltre che fondatore della squadra di calcio del Darfur United.
Probabilmente a muovermi è stato l’istinto del documentarista, il fatto di intravedere in quei pochi elementi a mia disposizione una possibile storia da raccontare, qualcosa di interessante, di profondo, che legava aspetti drammatici: la guerra, la fame, i rifugiati ad elementi più leggeri, ludici e universali: il calcio, lo sport più diffuso al mondo.
Nel 2011, Gabriel aveva deciso di creare una squadra calcio per fare parlare del Darfur. Dopo anni passati ad aiutarne la popolazione, si era reso conto di quanto fosse difficile raccogliere l’attenzione del mondo esterno proponendo soltanto storie di povertà e di fame e così, con un gesto provocatorio, ha deciso di utilizzare il calcio come leva, come strumento per arrivare a coinvolgere più persone.
Per questo suo atteggiamento propositivo e aperto, quando l’ho contattato per la prima volta, lui si è dimostrato entusiasta dell’idea di realizzare un documentario, e sicuro che, così come la squadra, il film avrebbe potuto attirare nuova attenzione sul Darfur e sui suoi problemi. Fin dai primi incontri c’è stata una grande collaborazione e Gabriel mi ha messo a disposizione le oltre 500 ore di girato originale raccolto da lui e da tutti i membri dell’ONG I-Act.
 E’ stata la mossa decisiva, quella mi ha tolto ogni dubbio e mi ha convinto a portare avanti questo progetto così difficile e impegnativo. Avere a disposizione una storia con un arco narrativo di 15 anni, per di più raccontata anno dopo anno dalle riprese video dei suoi protagonisti, è qualcosa che a un documentarista non capita ogni giorno, credetemi. In più, le riprese di Gabriel e del suo staff mi permettevano di “entrare” nella vita dei protagonisti in modo diretto, sincero ed originale. Negli ultimi anni sono stati fatti moltissimi documentari sul tema dei rifugiati e dei profughi, ma gli elementi a mia disposizione rendevano questa storia qualcosa di nuovo e di originale, e così per oltre due anni sono stato letteralmente catturato dal progetto “Not Just Football”.
E’ stata la mossa decisiva, quella mi ha tolto ogni dubbio e mi ha convinto a portare avanti questo progetto così difficile e impegnativo. Avere a disposizione una storia con un arco narrativo di 15 anni, per di più raccontata anno dopo anno dalle riprese video dei suoi protagonisti, è qualcosa che a un documentarista non capita ogni giorno, credetemi. In più, le riprese di Gabriel e del suo staff mi permettevano di “entrare” nella vita dei protagonisti in modo diretto, sincero ed originale. Negli ultimi anni sono stati fatti moltissimi documentari sul tema dei rifugiati e dei profughi, ma gli elementi a mia disposizione rendevano questa storia qualcosa di nuovo e di originale, e così per oltre due anni sono stato letteralmente catturato dal progetto “Not Just Football”.
Come è stato accolto il documentario? E che diffusione è riuscito ad avere?
Il documentario è stato accolto molto bene, soprattutto all’estero. Forse perché in Italia negli ultimi tempi va di moda il “cattivismo”, o perché abbiamo una certa (più umana e giustificabile) assuefazione verso storie che coinvolgono rifugiati, profughi o popolazione in difficoltà. La prima mondiale del film è stata in Messico, al Festival Internazionale di Città del Messico di fine ottobre, ed è stata seguita da numerose proiezioni nell’ambito del Global Migration Film Festival, rassegna sotto l’egida dell’ONU. Il film sta continuando il suo percorso di festival e a marzo sarò ospite di una rassegna internazionale a Berlino.
A livello distributivo, il documentario è distribuito dalla ADR di Milano e della Under The Milky Way di Parigi, per cui siamo ottimisti circa una sua prossima programmazione sui circuiti televisivi.
Il Darfur è uno dei molti conflitti dimenticati del mondo, come vivono questa condizione le persone che hai incontrato e che hanno fatto parte del progetto Not just football?
Parlando con Moubarak con gli altri ragazzi del Darfur United, si percepisce una profonda amarezza per il destino della propria terra. Sono anche dispiaciuti del fatto che in Europa e nel mondo ben pochi sappiano anche solo indicare il Darfur su una cartina geografica, ma a questo sono in qualche modo abituati: hanno capito che l’attenzione dei media può passare in pochi giorni da un’emergenza all’altra.
Al legame con la propria patria si unisce la difficoltà di rapportarsi con uno stato che li ha letteralmente cacciati dalle proprie case: i ragazzi che vivono nei campi profughi hanno lasciato il Darfur all’età di 8 o 10 anni e sono diventati adulti senza mai rivedere la propria terra.
Spesso in Italia ci chiediamo perché questi ragazzi decidono di investire tutto il denaro delle famiglie per abbandonare il proprio paese e cercare fortuna altrove, quasi che il loro fosse uno sfizio, una vacanza o il gesto codardo di chi abbandona il proprio paese senza lottare per cambiarlo..
Dopo aver visionato centinaia di ore di materiale video, dopo aver visto con i miei occhi come si vive in questi campi profughi, nella polvere, a 40 gradi di temperatura, in baracche di giunchi e di fango, vivendo di sussidi alimentari e senza alcuna speranza di riscatto, non posso che comprendere i loro motivi, la voglia di tentare altre strade, l’ essere disposti a tutto per provare a vivere un’altra vita.
 Credi che il documentario possa essere un reale strumento di sensibilizzazione?
Credi che il documentario possa essere un reale strumento di sensibilizzazione?
Io faccio documentari da oltre 10 anni e credo molto nel potere del documentario come strumento non solo di informazione, ma anche di sensibilizzazione. Un documentario permette di dare un volto, dei protagonisti reali e concreti, a temi che altrimenti restano astratti e lontani.
Che cosa ne sappiamo noi di un conflitto distante migliaia di chilometri? Quasi nulla, ma se associamo a questo conflitto dei volti, se conosciamo delle storie reali… ecco che cambia tutto, e possiamo entrare in empatia con queste persone e con questi temi. L’importante, a mio giudizio, è che il documentario non diventi qualcosa di militante, di partigiano, che non perda di obiettività, perché sennò può avere un effetto controproducente.
Nei miei documentari cerco sempre di inserire le voci critiche e di non nascondere le difficoltà, i problemi. Nel caso di “Not Just Football”, l’integrazione dei ragazzi in Svezia non è stata semplice, e alcuni di loro hanno commesso degli errori, che vanno raccontati perché il documentario possa restare realistico e credibile. Infine, per me l’ironia è una componente importantissima. Come ha ben capito Gabriel Stauring, raccontare solo storie di fame e di disperazione può avere l’effetto contrario, può allontanare le persone anziché sensibilizzarle e avvicinarle ad un tema tanto difficile ed importante.
Da sapere e per vedere Not just football
|











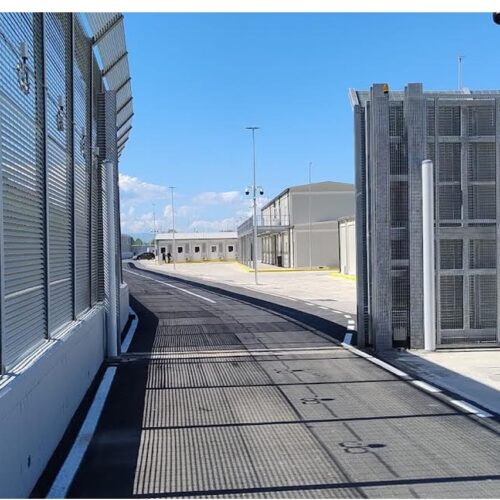











No comment yet, add your voice below!