
* di Miriam D’Elia
Recenti statistiche dell’UNHCR indicano la presenza di 149,000 rifugiati e richiedenti asilo in Uganda, di cui 37,298 sono registrati come rifugiati urbani nella città di Kampala. Il 65% circa proviene dalla Regione dei Grandi Laghi, la maggior parte di questi sono congolesi (UNHCR, 2010).
Sicuramente in questi ultimi anni il numero dei rifugiati congolesi all’interno dello stato ugandese è cresciuto notevolmente, a seguito del conflitto, ancora in corso, nelle regioni del Nord e Sud Kivu della Repubblica Democratica del Congo. La linea di condotta sui rifugiati adottata dall’UNHCR a partire dal 1997 raccomandava che i rifugiati venissero fatti confluire all’interno dei rural settlements, in quanto la gestione degli stessi rifugiati all’interno del contesto urbano si rivelava inefficiente e costosa. Ma questo provvedimento risultò irrealistico. Così la nuova politica “On refugee Protection and Solutions on Urban Areas”, del 2009, dichiarava: “The Office considers urban areas to be a legitimate place for refugees to enjoy their rights, including those stemming from their status as refugees as well as those that they hold in common with all other human beings.”
Tuttavia, questa clausola non è mai stata presa seriamente in considerazione e ancora oggi i rifugiati che decidono, per le ragioni più svariate, di stare in città, vivono in condizioni disumane, in città-slum alla periferia della capitale. A Kampala i rifugiati urbani sono esclusi da qualsiasi forma di protezione e assistenza, che è invece assicurata, anche se non senza problemi e aspetti negativi, nei rural settlements.
Tra i rifugiati urbani a Kampala troviamo persone con disabilità, donne vedove o single con a carico numerosi bambini, minori accompagnati. E sebbene il governo ospitante e tutte le organizzazioni coinvolte si aspettino da loro autosufficienza e autonomia, molti di loro sono incapaci di farlo.
Una ricerca: le rifugiate congolesi di Kampala
Miriam D’Elia, laureanda in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Torino, racconta a Vie di Fuga, tramite una toccante vicenda personale, l’esperienza diretta con i rifugiati urbani di Kampala. Si tratta di uno scritto che nasce all’interno di una ricerca e di un progetto che sta svolgendo nella capitale ugandese da quattro mesi. Il progetto si inquadra nelle attività di ricerca e cooperazione culturale della Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale del Dip.Culture Politica e Società sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e nell’accordo scientifico e didattico tra l’Università di Torino e Makerere University (Kampala). La ricerca sul campo, condotta autonomamente, è focalizzata sulle strategie di sopravvivenza delle donne congolesi rifugiate a Kampala e sulla continuità della violenza di genere.
Una storia personale: Elodie
Vi parlo di Elodie.
Vi parlo di lei perché la sua voce non viene udita. Forse perché troppo modesta o insignificante, la sua voce.
Elodie ha quarantacinque anni, ma come sempre il tempo sembra non passare mai per loro. Nessuna ruga, nessun segno dell’età che avanza. Solo due occhi enormi che aspettano di vedere una luce nuova e una pelle di seta.
Lascia tutto a Goma e scappa verso Kampala, senza obiettivi, senza progetti. Non c’è tempo, non un’alternativa valida da poter prendere in considerazione. Non un attimo di respiro. Così quattro anni fa, alle quattro di mattina, insieme ai suoi figli, viene scortata da un uomo attraverso la foresta al confine con l’Uganda. Da Rutshuru a Bunagana. E poi in pullman dritti fino a Kampala, passando dal distretto di Kisoro.
Era il 2008 quando Elodie e la sua famiglia decisero di scappare.
In quell’anno le truppe ribelli di Laurent Nkunda, con al loro fianco le milizie Tutsi, perpetrarono attacchi continui nei villaggi del Nord Kivu, sino ad arrivare alle soglie della città di Goma.
Nkunda dichiarò ufficialmente di esigere un’azione preventiva contro una nuova possibile repressione dei Tutsi da parte degli Hutu dopo il genocidio ruandese, ma in realtà le razzie e le violenze sui civili furono numerose.
Come se non bastasse all’interno del conflitto erano presenti anche l’esercito della Repubblica Democratica del Congo, inviato per contrastare l’avanzata di Laurent Nkunda, le milizie Hutu del Ruanda e una missione delle Nazioni Unite. Chi più ne ha, più ne metta.
I paesi occidentali decisero di non intervenire militarmente ma di inviare aiuti economici con fini umanitari e i ministri degli esteri britannico e francese si offrirono di fare da mediatori. Un misto di furbizia, pietismo, contraddizione e vigliaccheria; sempre, e questo è certo, a fine “umanitario”.
Comunque nello stesso anno anche l’esercito congolese perpetrò violenze nella città di Goma e nei villaggi attorno.
E nello stesso anno il marito di Elodie viene rapito, non si sa da chi.
“Dal giorno del rapimento i militari dell’esercito congolese venivano sempre a casa mia per maltrattarci. E nel 2009 si sono aggiunti altri gruppi.. venivano da me a chiedermi i soldi, perché mio marito aveva un buon lavoro e veniva da Rutshuru; e la gente che viene da lì parla il kinyarwanda (lingua ufficiale del Ruanda); allora venivano da me e mi dicevano “No, tu sei ruandese e ti uccidiamo..” Un’altra volta sono venuti, io avevo chiuso i miei figli in una stanza; loro hanno cominciato a chiedermi dov’erano i miei figli. Poi mi hanno portato in un’altra stanza e mi hanno violentata. Qualche giorno dopo sono andata all’uditorio congolese per fare denuncia sulla scomparsa di mio marito, ma dopo sono arrivati a casa di nuovo, hanno cominciato a buttare dentro casa dei gas lacrimogeni e ancora adesso mio figlio ha dei problemi agli occhi. Ancora adesso stiamo girando diverse cliniche. Da quando portarono via mio marito, venivano ogni volta a minacciarci, anche durante la notte. Mi seguivano anche quando andavo a prendere i miei figli a scuola..”
Così arrivano a Kampala, tutti tranne il marito. Nessuno parla l’inglese, e nemmeno il luganda (lingua ugandese). Ci si arrangia come si può, si dorme per due giorni davanti alla stazione di polizia. Poi, come per miracolo, Elodie incontra un ragazzo canadese che parla swahili e che decide di ospitarli a casa sua, di cercare dei vestiti nelle chiese e un po’ di denaro.
Il giorno del censimento dei rifugiati, a Kampala, Elodie ritrova suo marito. Un’attesa che sembrava non finire mai, una speranza quasi soffocata che rinasce in un istante. Qualcuno alle sue spalle grida il suo nome, grida il loro amore. Elodie si gira e sviene, è suo marito. Aveva passato quattro anni nella foresta, prigioniero e torturato dai militari.
“E piangendo ho detto agli ufficiali ugandesi che era mio marito.
Ora è a casa con noi, ma non esce perché i militari che l’hanno rapito in Congo sono qui; li ha già visti tre volte in città; ha fatto il rapporto alla polizia, ma non è cambiato nulla…
Non lavora e non esce di casa perché ha paura.”
Alle due incontro Elodie davanti all’ospedale di Nsambya. Ci diamo appuntamento per andare a casa sua. Passerò l’intera giornata con la sua famiglia. Mi abbraccia come se non mi vedesse da due anni. In realtà vado a trovarla spesso, ma per lei è sempre la prima volta. Le chiedo come sta, se sta lavorando. Mi dice che ha deciso di non vendere più i gioielli in città perché una sera, tornando a casa, è stata aggredita da alcuni uomini ugandesi che le hanno rubato la merce e l’hanno violentata. Un’altra volta. Un’altra maledetta volta il suo corpo si piega in due dal dolore e dalla vergogna. Non sarà mai più una donna come le altre, mai più degna del suo nome e della sua famiglia.
Ma il suo sangue non smette di scorrere, come linfa di una vita che continua.
E così, con una forza che solo lei conosce, si mette a cucire dei cappelli di lana; colorati, per raccogliere le trecce sul capo. Li cuce a casa e poi li rivende in città per quattromila scellini ugandesi. Si parla di pochi euro.
Mi dice che ha cominciato anche a fare il bucato per altre signore, ugandesi, congolesi e somale. Lo fa per guadagnare qualcosa in più, per riuscire a pagare gli studi ai figli. Si alza presto il mattino, corre anche dall’altra parte della città e immerge le mani nell’acqua insaponata. Con la schiena ricurva fino all’ultima camicia sporca.
“Ma è difficile, perché quando vado nelle case, ti danno una piccola quantità di vestiti; ma se trovi una signora che non è gentile, ti aggiunge della roba in più pagandoti uguale, oppure alla fine del lavoro si rifiuta di darti i soldi…
Parto il mattino, se ho dei clienti per il bucato faccio il bucato e poi ritorno a casa. Da quella volta che mi hanno violentata torno a casa molto presto.”
Arriviamo a casa sua. E’ già la quarta casa che cambiano, per via del marito, continuamente in pericolo. Questo è un posto tranquillo, isolato, alla periferia di Kampala.
C’è solo un salotto e una camera con dei materassi. Tutto è così rovinato, così umile e precario. Eppure c’è vita.
Il marito non è in casa. Elodie mi dice che è andato in ospedale a farsi visitare perché non riesce a dormire da una settimana. Forse è malaria, ma secondo lei suo marito non sta bene, a volte dice che vorrebbe uccidersi.
I figli invece sono tutti a casa, non hanno ancora ripreso ad andare a scuola dopo le vacanze natalizie. Ma anche quando sarà ora di rincominciare, solo due di loro lo faranno. Per gli altri non ci sono abbastanza soldi.
“Io non ho i soldi, gli prometto sempre che quando avrò i soldi potremmo fare questo o quello. Ma la vita è difficile.. devo cercare da mangiare, devo pagare l’affitto..”
Mi chiedono come sta la mia famiglia, che tempo fa in Italia, se ci sono molti rifugiati congolesi anche da noi. Incominciamo a scherzare, a insegnarci a vicenda l’italiano e lo swahili.
E così, una parola dopo l’altra, il tempo passa. Come se tutto fosse normale, come se le nostre vite si fossero incrociate per caso.
Eppure se guardo i loro occhi percepisco una luce strana, come se fosse opaca. Come se stessero lì, in attesa di qualcosa o sospesi su un filo a centinaia di metri da terra.
Ma è un’attesa fasulla e frustrante, perché loro stessi sanno che non arriverà mai niente, che non si può tornare indietro né lanciarsi in avanti. Tutto resterà così, tra dolore e resilienza.
“Meme si vous me donnez beaucoup d’argent, une voiture, la maison, je ne peux pas retourner au Congo. Il vaut mieux rester ici. Perché lì hanno rapito mio marito, mi hanno violentata, hanno maltrattato i miei figli..”
Bibliografia
Harrel-Bond, Imposing Aid: Emergency assistance to refugees, Oxford, 1986
Jacobsen K., The Economic Life of Refugees, Wes Hartford, Kumarian Press, 2005
Jourdan L., Generazione Kalashnikov. Un antropologo dentro la guerra in Congo, Laterza, 2010
The Refugee Act 2006 [Uganda], 24 May 2006, disponibile su: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7baba52.html
UNCHR, Urban Refugees and Livelihoods: surviving in the city, 2010










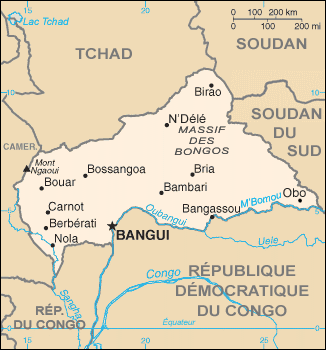
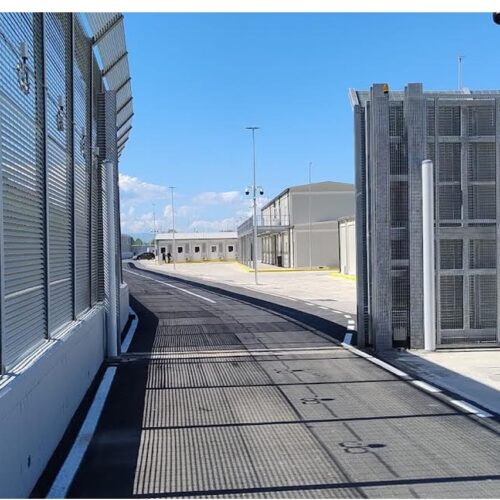











No comment yet, add your voice below!