Vie di fuga ha incontrato Colette Meffire, presidente dell’associazione Mosaico-Azioni per i rifugiati, a margine di un incontro su “Eredità coloniale, salute mentale e rivoluzione femminile” organizzato nell’ambito del Black History Month 2023 di Torino. Di origine camerunense, rifugiata, vive in un comune dell’hinterland torinese e insegna lingue.
 «Oggi al Black History Month ho parlato di ciò che abbiamo ereditato dal colonialismo nei nostri Paesi d’origine. Quando ci penso, quando penso ai danni, alla sofferenza causati dal colonialismo provo ancora rabbia, amarezza, frustrazione. E non è che la sofferenza è finita: oggi viviamo un’altra fase coloniale, forse ancora più crudele della prima. Oggi è business gestito da sfruttatori che non guardano in faccia a nessuno, che non si preoccupano se bambini muoiono o donne vengono maltrattate. Con la complicità di alcuni africani. Ecco, qui oggi ho parlato della rabbia che proviamo. Però bisogna riconoscere che, in positivo, abbiamo almeno ereditato delle lingue che ci permettono di girare il mondo, di farci capire da tutti. In Camerun abbiamo due lingue ufficiali, l’inglese e il francese, gli strumenti giusti per trasmettere alle persone la nostra rabbia e la nostra delusione per quello che ci hanno fatto e continuano a fare, ma anche per lanciare un appello: come ha detto papa Francesco di recente nella sua visita in Congo-Kinshasa, l’Africa non è una miniera da sfruttare. Certo è una battaglia difficile, perché è la stessa Europa “dei diritti” a permettere, a mandare i propri cittadini a sfruttare i nostri Paesi».
«Oggi al Black History Month ho parlato di ciò che abbiamo ereditato dal colonialismo nei nostri Paesi d’origine. Quando ci penso, quando penso ai danni, alla sofferenza causati dal colonialismo provo ancora rabbia, amarezza, frustrazione. E non è che la sofferenza è finita: oggi viviamo un’altra fase coloniale, forse ancora più crudele della prima. Oggi è business gestito da sfruttatori che non guardano in faccia a nessuno, che non si preoccupano se bambini muoiono o donne vengono maltrattate. Con la complicità di alcuni africani. Ecco, qui oggi ho parlato della rabbia che proviamo. Però bisogna riconoscere che, in positivo, abbiamo almeno ereditato delle lingue che ci permettono di girare il mondo, di farci capire da tutti. In Camerun abbiamo due lingue ufficiali, l’inglese e il francese, gli strumenti giusti per trasmettere alle persone la nostra rabbia e la nostra delusione per quello che ci hanno fatto e continuano a fare, ma anche per lanciare un appello: come ha detto papa Francesco di recente nella sua visita in Congo-Kinshasa, l’Africa non è una miniera da sfruttare. Certo è una battaglia difficile, perché è la stessa Europa “dei diritti” a permettere, a mandare i propri cittadini a sfruttare i nostri Paesi».
Colette Meffire è fuggita in Italia nel 2010. Giornalista, nel suo Paese ha lavorato per quasi un decennio in un’emittente privata, Radio Equinoxe, nata su scala regionale e poi passata a trasmettere in tutto il Camerun.
«Eravamo diventati una radio dei “senza voce” – ricorda -. Raccontavamo la realtà. E desideravamo la fine della dittatura del governo che purtroppo ancora oggi è al potere. Perché abbiamo lo stesso presidente da 40 anni (Paul Biya, ndr), che il 13 febbraio ha festeggiato i 90 anni d’età… Comunque, in un clima di assenza di libertà di stampa, a un certo punto abbiamo ricevuto minacce e il governo ha chiuso la radio due volte, perché secondo loro eravamo pericolosi per la società camerunense. Così dopo l’ultima chiusura, nel 2008, ho deciso che dovevo andarmene, anche per proteggere la vita di mio figlio e della mia famiglia». Nel dicembre del ’10 la richiesta di protezione internazionale nel nostro Paese. «Poi nel giugno dell”11, lo ricordo bene, era il 14 di giugno, è arrivata la risposta. Devo dire che sono stata fortunata, perché in quel periodo ho incontrato richiedenti asilo che aspettavano l’esito da un anno, o anche due. A me è andata liscia, dopo sei mesi ero ufficialmente una rifugiata». Colette potrà riabbracciare suo figlio solo quattro anni dopo, anche se fin da subito ha fatto di tutto per permettergli di arrivare in Italia.
Come professione si è scelta quella di docente di inglese e francese nelle aziende. «Non dicevamo che è l’aspetto positivo della colonizzazione? (sorride)… Anche se entrare nel settore come donna di colore e soprattutto di origine africana non è facile». Ancora oggi? «Sì, ancora oggi, perché rimane come una barriera. Nel 2010, quando ho chiesto asilo, c’era il famoso modulo C3 da compilare e la funzionaria della Questura mi ha chiesto quanti anni di studio avevo. Io: “Quasi 20”, e lei stupita: “Come mai?”. Le suonava strano».
«Ma capita anche quando vado a cercare lavoro – continua Meffire –. In un’agenzia di collocamento una volta mi hanno detto che il mio CV è “troppo ricco”. Per me è una sfida continua. Con un altro mestiere avrei potuto avere contratti anche a tempo indeterminato, che di sicuro non ho con questo. Ma voglio dimostrare che le donne africane sono in grado di fare ciò che tante persone non credono. Un altro episodio: mi è capitato di chiacchierare con una signora che mi ha subito chiesto se ero una badante. “No, faccio l’insegnante”. “Però! Brava, come hai fatto?”. “Ho studiato, signora…”».
 Colette, lei è anche presidente di un’associazione italiana… «No, Mosaico è un’associazione creata dai rifugiati per i rifugiati. Quando sono arrivata, l’associazione era già nata da alcuni anni. I fondatori si sono impegnati per evitare ai richiedenti asilo arrivati dopo di loro ciò che loro avevano vissuto: la fatica di inserirsi, ma anche solo di trovare un tetto, di essere accettati. Prima erano gli italiani che raccontavano la nostra storia, oggi abbiamo cominciato a raccontare noi quel che viviamo. A Mosaico stiamo provando a cambiare la società: quando sono arrivata, i rifugiati non potevano andare all’università, soprattutto i rifugiati africani….». Non venivano riconosciuti i loro titoli di studio? «No, nulla. La filosofia dei progetti di formazione era: se sei donna fai la OSS o la badante, se sei uomo la strada è quella della fabbrica. Noi però pensiamo che i giovani che arrivano possano aspirare anche a qualcos’altro. In uno dei nostri progetti abbiamo un accordo con l’Università di Torino per l’orientamento e il riconoscimento dei titoli».
Colette, lei è anche presidente di un’associazione italiana… «No, Mosaico è un’associazione creata dai rifugiati per i rifugiati. Quando sono arrivata, l’associazione era già nata da alcuni anni. I fondatori si sono impegnati per evitare ai richiedenti asilo arrivati dopo di loro ciò che loro avevano vissuto: la fatica di inserirsi, ma anche solo di trovare un tetto, di essere accettati. Prima erano gli italiani che raccontavano la nostra storia, oggi abbiamo cominciato a raccontare noi quel che viviamo. A Mosaico stiamo provando a cambiare la società: quando sono arrivata, i rifugiati non potevano andare all’università, soprattutto i rifugiati africani….». Non venivano riconosciuti i loro titoli di studio? «No, nulla. La filosofia dei progetti di formazione era: se sei donna fai la OSS o la badante, se sei uomo la strada è quella della fabbrica. Noi però pensiamo che i giovani che arrivano possano aspirare anche a qualcos’altro. In uno dei nostri progetti abbiamo un accordo con l’Università di Torino per l’orientamento e il riconoscimento dei titoli».
Meffire ricorda anche il progetto “Non siamo sole“, che accompagna un gruppo di donne rifugiate nella ricerca condivisa di soluzioni per il lavoro, la casa, l’inclusione. E commenta: «Le persone pensano, non so se è la società italiana che l’ha messo in testa ai rifugiati e ai migranti che arrivano, che possono soltanto chiedere e magari avere, invece di partecipare alla costruzione del futuro del Paese. Noi però continuiamo a dire ai giovani che arrivano, uomini e donne, che possono sognare, sì, sognare in grande…».
Sognare nell’Italia di oggi, possibile? «Sì, direi… piano piano, passo a passo. Prima non potevano andare all’università, oggi possono. C’erano mestieri già stabiliti per loro, oggi hanno anche altre possibilità: studiare, fare l’insegnante come me… Certo non è facile, bisogna metterci del proprio. Se il cambiamento ce lo aspettiamo dallo Stato non verrà mai. Dobbiamo dimostrare e far caprie che facciamo parte della cittadinanza, siamo già “cittadini”. E che per l’Italia possiamo essere una risorsa. Io so di non essere un peso per nessuno, qui».
L’incontro con Vie si chiude come era iniziato, sull’Africa e sul Camerun 13 anni dopo: 13 anni dopo il 2010 dell’esilio. «Purtroppo nel mio Paese le cose peggiorano. Qualche settimana fa sono stati uccisi due giornalisti. Quindi la libertà di stampa non esiste. E la corruzione rimane a livelli elevati». Reporters san frontières definisce il Camerun come uno degli Stati africani più ricchi e vitali sotto il profilo dei media, ma anche fra i più pericolosi per i giornalisti, costretti a lavorare in un ambiente ostile e precario. Il Paese rimane nell’orbita della “Françafrique”, anche se, osserva Meffire, «non c’è solo la Francia a sfruttarci, ma anche inglesi, americani, tedeschi, cinesi. In molti ci chiediamo se ce la faremo mai a uscire da questa trappola, da questi matrimoni non voluti. Avremmo bisogno di business “win win”, quello che porta vantaggi a entrambe le parti. Ma purtroppo non è così. E le condizioni di vita per i camerunensi non migliorano. Oggi c’è la guerra in Ucraina, ma perché doveva soffrirne anche l’Africa? Perché dipendiamo dall’Ucraina per il grano? La terra ce l’abbiamo anche noi. Il fatto è che la globalizzazione ha impedito a Paesi come il Camerun di essere veramente indipendenti. Non è che siamo poveri, abbiamo miniere, risorse naturali, perché non possiamo goderne, perché dobbiamo lasciare che siano gli altri a usare, a prendere? Mentre le persone continuano a soffrire e a vivere nella precarietà».











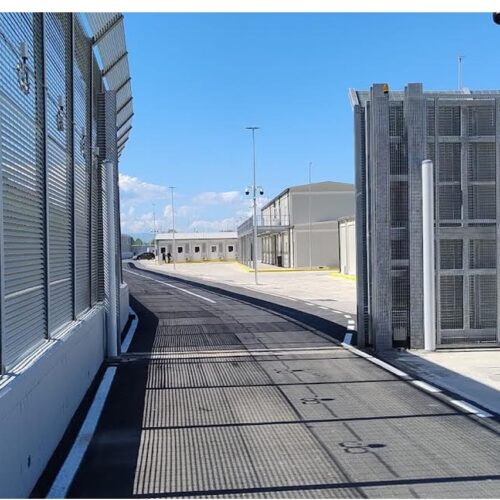











No comment yet, add your voice below!